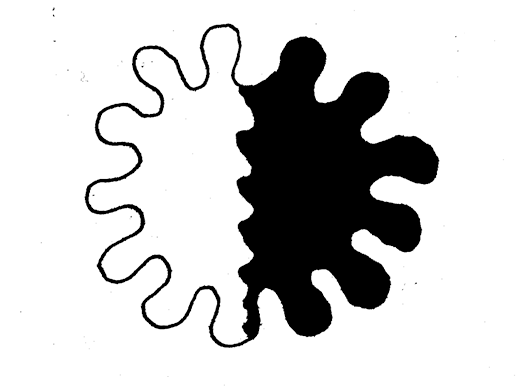Quando dopo un miliardo di anni di storia evolutiva i cianobatteri impararono a estrarre elettroni dall’acqua, l’atmosfera fu lentamente invasa del residuo di reazione, un pericoloso gas tossico: l’ossigeno. Durante la “Grande Ossidazione” sappiamo che qualche cellula imparò prima a proteggersi, poi a utilizzare l’ossigeno, e infine a respirare. Da lì è un passo alla comparsa della specie umana (si veda [Sandal, 2019] per una esposizione divulgativa).
Oggi già esistono batteri e organismi in grado di metabolizzare la plastica e gli altri prodotti degli idrocarburi. Forse saranno loro a far partire una nuova vita, in una nuova atmosfera, quando l’endling umano avrà già da lungo calcato il suolo terrestre. In bocca al lupo a tutti loro!
L’estinzione delle specie certo ci spaventa. Specie della nostra. Ma forse più della fine stessa ci preoccupa il come finiremo. Matteo Meschiari, ne La Grande Estinzione (2020), denuncia l’estinzione di un immaginario collettivo come strumento di sopravvivenza. O forse direttamente della collettività.
Che cosa sta sparendo? E cosa compare al suo posto? Basta davvero un gioco che ribadisca che c’era un immaginario condiviso, lo si può ancora ricostruire, è divertente e necessario farlo insieme? Saranno le distanze culturali, generazionali, materiali a prevalere, o magari la vocazione intrinsecamente ibrida dei nostri paesaggi?
In questo pezzo, scritto a quattordici mani, raccogliamo la proposta di Matteo Meschiari di recensire (o meglio: di divagare a partire da) il suo manifesto. Ci siamo lasciati prendere la mano.
[…continua su La Grande Estinzione]
Trame: o di paesaggi, linguaggi, e conoscenze
Recentemente, attraversando le Marche, ci siamo imbattuti in quello che subito ci è sembrato un dipinto: osservavamo la fusione dell’organizzazione dei poderi con l’orografia, in una progettazione sopra i singoli confini che richiama le immagini fissate su una tela. Una cornice non saprebbe includere, però, crescita e frutti, piogge e siccità, attesa e lavoro, l’identificazione reciproca tra il territorio e chi lo attraversa. Quel paesaggio non è sorto tra spatole, pennelli e raschietti, e non è neppure dipinto dagli aratri che trasformano il terreno nel raccolto. È invece una complessità fatta non di giustapposizione di realtà distinte (quella umana e quella naturale, sia essa pittoresca o sublime), bensì di immersione reciproca, dove il paesaggio è il processo stesso. Uno scenario che pare incorruttibile ma in cui immaginazione e prassi sono parte di un processo dinamico.
L’architetto norvegese Sverre Fehn si rapportava con i ghiacciai, presenti nel suo paesaggio nordico, come fossero creature viventi capaci di scivolare sulla terra e custodire memorie. Non saper più percepire questi intrecci continui è forse sintomo dell’imminente compromissione. Ad un’attenta analisi i paesaggi si rivelano soggetti “immaginanti”: tramite il nostro linguaggio agiscono su di noi tanto quanto noi su di loro.
Perciò non è possibile concepire e comprendere le origini di una qualsiasi lingua naturale e i suoi parlanti fuori dal contesto ambientale in cui si sviluppano le comunità umane (si vedano in proposito [Alinei e Benozzo, 2015]). Lo studio delle tradizioni orali evidenzia il legame imprescindibile che si instaura tra il linguaggio-pensiero umano e il paesaggio abitato, come insegnano l’etnolinguistica e più in generale le discipline etno-antropologiche. Linguaggio è paesaggio e paesaggio è linguaggio.
Tra le grandi estinzioni che ci riguardano menzioniamo allora il genocidio linguistico in atto – secondo le stime medie, delle circa 6.000 lingue sul pianeta, ogni anno ne muoiono 30-40. Il fenomeno è strettamente collegato alla crisi ecologica, poiché le comunità linguistiche più piccole, e quindi già a rischio di estinzione, sono proprio le più deboli davanti all’avanzata di un sistema di sfruttamento economico, sociale, ambientale planetario, addirittura universale (continuiamo a coltivare ambiziosi progetti nello spazio…). Eppure ogni lingua che muore ci priva di una cosmovisione assolutamente unica, di un vero e proprio universo che costituiva il sistema di pensiero, di organizzazione della realtà, oltre che tutto il bagaglio di conoscenze condivise dei parlanti.
Uno dei paradossi contemporanei più problematici è il rapporto tra questi due binari che viaggiano in parallelo: l’esponenziale crescita demografica che genera sempre più parlanti da decenni e l’affermazione di un solo discorso dominante sul pianeta. Si tratta di un’egemonia tanto ontologica, epistemologica, culturale, economica, sociale, politica quanto linguistica: una minoranza di lingue relativamente “simili” tra loro che colonizza un paesaggio sempre meno immaginato e più uniforme a livello globale. Ma linguaggi e paesaggi sono terre feconde che amano gli innesti e le contaminazioni. Come i corpi che abitiamo non saprebbero esistere senza batteri e virus, così anche laddove una potenza europea piazza la propria bandiera e impone la sua lingua, nascono dei meravigliosi ibridi (creoli, pidgin), così come in tutti i contesti che conoscono migrazioni e movimento.
Estinzioni in scala
Se Meschiari da un lato si intrattiene con megafauna e malware, l’anno scorso a Scienceground ci siamo divertiti a parlare di microbi. In questo contesto la parola “estinzione”, usualmente connotata negativamente, assume nuovi significati: ed è proprio un punto di forza della scienza di tentare di dare un significato preciso alle parole. Nel senso propriamente scientifico, estinzione significa che cessa di esistere una specie vivente. Qualcosa che dunque è all’ordine del giorno, per esempio, per virus e batteri. Per i biologi, due esseri viventi sono definiti della stessa specie se riescono a riprodursi tra loro con successo. La riproduzione, si sa, è l’unico meccanismo che consente di replicare dei tratti nel tempo e, eventualmente, di evolverli – per questo l’estinzione della sete di conoscenza è una cosa molto difficile: una risposta ad una domanda ne genera normalmente almeno altre due! Nel caso dei microbi, la definizione di specie è un po’ più complessa perché non c’è una vera e propria riproduzione – i batteri difficilmente fanno all’amore. A volte fanno quella che si chiama “coniugazione”, cioè estromettono dei filamenti con cui si scambiano segmenti di DNA, che alla fine è quello che conta. Insomma un metodo pratico di corrispondenza evolutiva. Il problema è che qualsiasi batterio può coniugarsi con un altro, oppure se proprio non trova nessun* può sempre far replicare il proprio DNA e dividersi in due, sperando in qualche mutazione che mantenga un minimo di biodiversità. Quindi c’è una sola specie batterica? No, perché comunque i batteri sono tanti, alcuni vivono solo se c’è ossigeno, altri proprio se non ce n’è nemmeno una traccia, alcuni si muovono, altri sono verdi. Insomma: di nessuna erba spontanea si può fare un fascio.
I ricercatori si sono accorti che normalmente la diversità batterica si correla bene con la diversità di “basi”, cioè di “lettere”, di una sequenza di DNA, che hanno chiamato 16S. La disposizione e il tipo di lettere che compongono questa parola lunga circa 2000 caratteri rendono conto delle differenze tra circa 9000 specie batteriche. Quindi è chiaro che è molto facile che una specie si “estingua” in un’altra, basta cambiare un paio di lettere: alcuni batteri si dividono ogni dieci minuti, si calcola che cambiano almeno 4 lettere al giorno. Eppure di queste estinzioni quotidiane nessuno si preoccupa, i giornali non ne parlano. Forse perché i microbi ci toccano meno che l’uccello parrocchetto della California o il melomys rubicola australiano? Strano, visto che lieviti e batteri costituiscono lo 0.2% del nostro peso corporeo, consentono molti processi a partire dalla digestione, sono alla base della gran parte dei cibi che mangiamo quotidianamente, rendono fertili i nostri suoli e tante altre cose. Allora forse è una questione di ordini di grandezza, le estinzioni che riguardano i batteri sono talmente piccole rispetto alla vastità della diversità batterica da non essere tangibili? Non è nemmeno così, un’estinzione molto tangibile è quella dei batteri che erano sensibili a vari antibiotici. L’occorrenza della resistenza antibiotica è un problema particolarmente grave oggi, alla pari dei cambiamenti climatici [Davies, 2013]. Tuttavia non è contro la resistenza antibiotica che nell’ultimo anno sono scese in piazza milioni di persone. E neanche per il parrocchetto.
Interiorizzare il disastro
Nel momento in cui la crisi ambientale ha preso posto nelle coscienze, non necessariamente nelle forme più auspicabili, il paesaggio contemporaneo si è trasformato in linguaggio psicotico degno dell’attenzione di una linguistica clinico-ecologica. La semantica e la sintassi del paesaggio contemporaneo sono stravolte e instabili, come la fragile psiche umana.
Nel 2005 il filosofo australiano Glenn Albrecht coniava il termine solastalgia per esprimere il disagio mentale/esistenziale causato dai cambiamenti ambientali, intesi sia come fenomeni locali che nella dimensione globale del cambiamento climatico (responsabile appunto della imprevedibilità o violenza catastrofica di molti fenomeni meteorologici e “naturali” degli ultimi anni) [Albrecht, 2005].
Nel 2017 l’American Psychiatric Association definisce l’eco-ansia come “paura cronica” di environmental doom, espressione che non ha un immediato corrispondente in italiano, ma che potremmo approssimare con “apocalisse ambientale”.
Negli Stati Uniti la psicologia si preoccupa sempre di più di come “gestire” quest’ansia, le cui manifestazioni variano ovviamente tantissimo in base agli individui, alla sensibilità e coscienza ambientale di ciascuno, ma sembrano interessare sempre maggiormente la collettività: si pensi per esempio alla diffusione e amplificazione di sentimenti di allarme e panico sui social media, fenomeno acutizzato in presenza di determinati eventi rilevanti (i recenti incendi in Australia, per esempio).
Le riflessioni sull’eco-ansia rimangono tuttavia concentrate sul supporto psicologico-terapeutico da fornire alle pecorelle sperdute delle greggi globali: i migliori rimedi, le terapie appropriate.
Un approccio soluzionista che non rimette in discussione la narrazione antropocentrica del nostro rapporto con la natura. Dal momento in cui identifichiamo questa ansia cronica come una condizione psichica (non è classificata come sindrome dal Manuale diagnostico, attenzione) che, per quanto stimolata esternamente, agisce dall’interno, è evidente che è da qui che dobbiamo ripartire.
Continuando a rappresentarci il mondo nell’ottica sostanzialmente binaria che, nonostante tutti i relativismi etici e filosofici, ha sempre orientato in gran parte la nostra visione del cosmo, tanto vale gridare all’apocalisse su Facebook e Twitter quanto decidere di non comprare più niente di implasticato al supermercato (buona fortuna!) o usare i mezzi pubblici invece della macchina per andare a lavoro.
La Grande Spiegazione
La scienza, praticata da tante comunità in luoghi geografici distanti e condizioni diverse, può giocare un ruolo rilevante nella condivisione ed elaborazione del disagio. Una delle epifanie più nitide che abbiamo avuto leggendo La Grande Estinzione è che anche la scienza è un paesaggio: una narrazione che nasce come modo di percepire, pensare e plasmare il mondo. Come gli animali che i primi sapiens non potevano vedere con gli occhi, anche gli oggetti scientifici sono fatti per essere visti mentalmente. Le forze agenti su corpi puntiformi, i momenti, le onde elettromagnetiche, l’entropia, gli atomi, le particelle subatomiche…tutti questi concetti – al pari del mammut che “ora non vedo, ma che ha lasciato quest’orma” – fanno parte del modello cognitivo con cui ci spieghiamo la realtà esperibile. Fare scienza è costruire un immaginario per spiegare il mondo.
O almeno era così. Sempre più sintomi ci fanno capire che la scienza sta perdendo la sua spinta poietica: alla creazione di nuove narrazioni figlie dello stupore per l’inatteso, si sta sostituendo un’asfissiante rincorsa di quello che ci si aspetta di trovare, una caccia alla conferma. Certe comunità di scienziati stanno morendo di stenti proprio come orde di cacciatori che camminano per giorni inseguendo l’ipotesi di un ungulato che non si trova. Imitando Meschiari, possiamo pensare all’impresa scientifica come a un grande gioco in cui lo scopo è spiegare il mondo, si potrebbe chiamare “La Grande Spiegazione”. Anche in questo caso si può parlare di sospensione dell’incredulità, o meglio della criticità dei giocatori: la maggior parte di essi converge verso la medesima strategia, quella del metodo scientifico, e la assume come l’unica possibile. La conoscenza si produce secondo una ricetta che, data un’ipotesi, permette di stabilirne una sorta di valore di verità. Finché l’ipotesi non viene falsificata essa entra di diritto nella nostra narrazione del mondo. Il problema è che la ricetta metodologica non insegna né come produrre buone ipotesi, né come scegliere quelle più promettenti. Per quanto riguarda la scelta, per dirla con le parole con cui Sabine Hossenfelder descrive la fisica moderna, la scienza va avanti con il principio del “just look” [Hossenfelder, 2018]. Mancano agli scienziati gli strumenti filosofici e sociologici per valutare le ipotesi, e così tutte vengono guardate nello stesso modo e meritano di essere testate. Come con l’ungulato ipotetico, l’inseguimento può però durare a lungo e richiedere un dispendio di risorse oltremisura, soprattutto in quei casi in cui l’ipotesi non è falsificabile, ma solo verificabile – il “not ever wrong” di Pauli, ripreso da Peter Woit per una serrata critica di certi programmi di fisica teorica [Woit, 2007]. Quello che nel pleistocene poteva suonare come un “Edward, anche oggi non abbiamo trovato il mammut, ma se domani acceleriamo il passo lo potremo raggiungere, me lo sento” oggi è un “Professore, anche stavolta nessun segnale ascrivibile alle stringhe, ma tra pochi anni saremo in grado di aumentare la potenza dell’acceleratore e trovarle, me lo sento”. Per quanto riguarda la produzione di ipotesi, il problema è forse più esteso. Anche qui si osserva un progressivo atrofizzarsi dell’immaginazione, con gli scienziati convergenti prede dell’omologazione e strenui paladini di quella che Kuhn chiamava scienza normale [Kuhn, 2009], che chiamano “ricerca” quella che in realtà è un’imbarazzante difesa degli status quo delle varie discipline.
Questo è tanto più lampante nella fisica. Regina delle scienze nel ventesimo secolo, sempre più fantomatica (la trilogia accennata da Meschiari: da scienza della materia, poi dell’energia, ora è in gran parte scienza dell’informazione), nel ventunesimo tanta fisica è ancella di progetti di governance globale basati sull’appiattimento del mondo a una montagna di dati numerici – enormi in quantità, ma spesso non in qualità. Basti osservare come l’istituzione CERN (da non confondere con la comunità che abita il CERN), esaurito il suo potere di generare immagini (chi se ne frega più della particella ultima?), si stia riqualificando come centro globale di data science.
Science (and) Fiction
In questo ristagnare, abbiamo l’impressione di essere nel penultimo tratto della storia umana: abbastanza lontani dall’inizio per non ricordarlo, non ancora travolti da una fine che si minaccia prossima.
È il momento in cui e di cui vale la pena scrivere, ma è anche un intermezzo pericoloso: cosa accade agli spazi penultimi se la fine si espande e diventa cronica? Si fanno spazio, per esempio, i riflessi inconsistenti che oggi riempiono le tendenze narrative di rappresentazioni pop sull’estinzione e l’apocalisse: quando una società non riesce più a immaginarsi come tale, si limita a rappresentarsi in un immaginario che riproduce se stesso e, nel farlo, si serve di goffe imitazioni di quello che sembrava l’ultimo paradigma legittimo: il discorso scientifico. Non stupisce questo fare il verso alla scienza: dopo che l’abbiamo indicata come modello e allo stesso tempo abbiamo preteso di negarle il suo posto nel mondo, considerandola apolitica, ne abbiamo fatto il mezzo ideale per autoassolverci come specie. Ma non è bastato: ora che anche la scienza ha smesso di produrre risultati soddisfacenti, paradossalmente, deve incontrarsi con ciò che dovrebbe o vorrebbe essere il suo opposto: la finzione. Se guardiamo al collasso ambientale da questo punto di vista, troviamo una disciplina dove l’immaginario scientifico e quello letterario si contaminano e alimentano, corroborando al contempo la cosmologia dell’Antropocene con dati sempre più allarmanti e narrazioni che non lasciano scampo. Si arriva dunque all’uroboro di una scienza sempre più condizionata da un immaginario figlio della cosmologia dell’Antropocene che essa stessa contribuisce a creare.
Che le opere di fiction influenzino la percezione della realtà, anche scientifica, è un fatto evidente, ma è possibile girare quest’arma a proprio vantaggio smettendo di soffocare le finzioni e anzi, in un certo senso, moltiplicandole? Ne L’uomo è antiquato, scritto dopo Hiroshima e Nagasaki, quindi in piena psicosi da “grande estinzione”, una delle maggiori colpe che Günther Anders attribuisce all’uomo è quella della scarsa capacità di immaginare: figurarsi una catastrofe atomica è difficile, e anche la locuzione “arma di fine del mondo” suona solo come una sequenza di parole che non si trasformano in immagini.
Proprio quella mancata capacità di immaginare la bomba ci ha permesso, dice Anders, di produrla. La fine di cui parla Meschiari è diversa, somiglia di più al Big Rip che al Big Crunch, per dirla in modo pop: una lenta fine lamentosa nella notte dei tempi, ma la sostanza è che la fine è difficile da immaginare in termini assoluti, ancor di più “pensarla altrimenti”, quindi ci si accontenta di una non-fine con gli zombie. In questo il compito della letteratura è enorme.
A colmare questo vuoto devono pensarci le finzioni letterarie, il cui ruolo non è solo quello di immaginare, ma di coivolgere al punto da distorcere il modello (attenzione, non la realtà) attuale. Non basta sapere di una minaccia imminente, ma bisogna anche crederci: riprendendo Safran Foer, “tutti gli ebrei polacchi sapevano che la minaccia nazista si stava avvicinando e concretizzando. Quelli che, oltre a saperlo, ci credevano, hanno avuto la forza per compiere una scelta radicale: hanno abbandonato la loro casa e si sono salvati – la nonna di Foer era una di loro”, come ha raccontato recentemente Federico Casotto. La voluminosità crescente del rapporto dell’IPCC sul cambiamento climatico che esce ogni cinque anni non lascia dubbi sul grado di consapevolezza del disastro che la scienza contemporanea sta raccogliendo. Eppure la scienza stessa sembra incapace di indurre la società a crederci – mentre i miti orali con cui i nativi amerindi si trasmettono le conoscenze continuano a essere vivi: sono conoscenza e credenza allo stesso tempo [Kopenawa e Albert, 2013]. Come fare quindi a non lasciare lettera morta una enorme mole di conoscenza?
Perché scienza e fiction collaborino per ritrovare un’efficacia reciproca, è necessaria una narrazione che non sia quella d’intrattenimento che ripropone scenari apocalittici o disastri da cui salvarsi – sempre ognuno per sé, ripiegati sulle responsabilità individuali ma comunque impegnati a salvare il mondo, possibilmente prima di cena [Safran Foer, 2019]! Serve piuttosto una narrazione-esercizio: forse siamo troppo impegnati a fare fact checking per accorgerci che non si tratta più di separare il falso dal vero sul piano contingente: la realtà che osserviamo non è mai vera o falsa, possiamo invece domandarci se ci si può fidare della lente con cui la stiamo guardando, addentrandoci così in giochi caleidoscopici che ci portano all’origine della domanda, forse mai alla risposta. Si tratta allora di imparare a proiettarsi, amplificare l’immaginario attraverso il recupero del fantastico, del mito, degli dèi come strumento concreto di militanza: un’immaginazione resistente che si oppone al mantra del “non ci sono alternative” e che chiede, pure nell’urgenza, una sospensione. Da quando abbiamo perso il controllo dei miti – fondamenta su cui per secoli si è costituito l’ordine sociale – i miti hanno iniziato a controllare noi: anche quando un discorso sulla fine è diventato ineludibile, le nostre capacità di immaginare non riescono a tenere il passo dei cambiamenti. Finché considereremo i miti che hanno caratterizzato gli albori della civiltà umana come mere rappresentazioni artistiche – nell’accezione puramente “estetica” del termine – o narrazioni favolesche, invece che tecnologie po(i)etiche di sopravvivenza ed evoluzione, non riusciremo ad apprezzare la piena portata del contributo che hanno dato alla storia della specie umana e a (ri)appropriarcene per garantire il nostro futuro.
Che cos’è l’immaginario?
L’immagine/segno è una tecnologia che abbiamo a disposizione fin dalle origini della nostra specie. Uno strumento vivo, che interagisce con il mondo e che può quindi essere uno strumento di socializz-azione, di mediazione tra la realtà e la coscienza/conoscenza che abbiamo di essa. L’immaginario diventa così una delle tecnologie più necessarie di questi tempi, tanto più quando agisce in sinergia con quelle che il progresso scientifico ha affinato con tanti sforzi negli ultimi secoli.
Un bellissimo saggio sulla Scienza Nuova, opera seminale di Gian Battista Vico, analizza quest’ultima proprio attraverso il triplice prisma: immaginazione, immagine, immaginario [Spadaccini, 2010]. L’autore individua questa “novità” annunciata da Vico in una “scienza dell’immaginario, quella che avrà di mira la comprensione del mondo umano e del suo farsi a partire da ciò che esso espone come fittizio e nondimeno come vero”. La soluzione che Meschiari (ri)propone alle urgenze del mondo contemporaneo è ben più vecchia dei disastri globali che caratterizzano attualmente l’Antropocene, anche anteriore al XIX secolo in cui scrive il grande umanista italiano, che tuttavia ha il merito fondamentale di aver individuato nell’immaginario ciò “che rende l’uomo alla sua forma umana. E che si presenta come ciò che l’essere umano ha di più proprio”. Concentriamoci un attimo sulla stretta connessione individuata tra immaginazione-sopravvivenza-salvezza. Gli esseri umani hanno sviluppato un sistema sempre più complesso di rappresentazioni simboliche che si sono (in realtà “ci hanno”) evoluto fino ad arrivare allo stato attuale di complessità e diversità dei segni linguistici che contraddistinguono la nostra specie, ma che dire della comunicazione delle piante? Le acacie sembrano in grado di comunicare in maniera perfettamente efficace ai fini della propria salvaguardia. Per non parlare degli animali, dai quali abbiamo a lungo preteso di distinguerci proprio in virtù del nostro linguaggio, una facoltà così “specifica” ai sensi della biologia, universale criterio di umanità versus animalità. Eppure le nostre raffinate tecnologie simboliche hanno avuto origine da esigenze bestiali, predatorie, e si espandono i confini delle capacità comunicative degli (altri) animali – grandi mammiferi e uccelli ma non solo, o meglio si spostano le frontiere della nostra conoscenza e comprensione dei segnali animali.
È in questo gioco di scale che, per non entrare in contraddizione, le scienze naturali e le scienze dell’immaginario possono e devono entrambe venire in aiuto della ragione umana, quando essa tenta di confrontarsi con le distanze (quasi) incommensurabili che ci separano da un batterio o da un atomo o da un quark, o degli anni luce dalle stelle più vicine. Le scienze naturali necessitano oggi più che mai degli strumenti di riflessione critica di discipline umanistiche quali la filosofia o la sociologia, mentre hanno sempre sfruttato il potere dell’immaginazione e delle rappresentazioni mentali per oltrepassare i limiti contingenti dell’esperienza, almeno nelle fasi di ipotesi di teorie poi provate fisicamente (oppure no…n ancora). Eccezion fatta per le scienze matematiche, che nella loro dimensione più pura rappresentano l’astrazione mentale per eccellenza!
Quando nel XIX secolo Mark Twain si metteva nei panni di un uomo diventato microbo, il cui intero universo si ridimensionava nei limiti di un corpo umano, l’esperimento narrativo era d’iniziativa originale, eppure il risultato è piuttosto una caricatura dell’antropocentrismo che ha sempre dominato il rapporto umano con gli altri esseri viventi e non [Twain, 1996]. Oggi, anche grazie a conoscenze più approfondite dei meccanismi di funzionamento delle piante, degli altri animali, dei microrganismi (che pure esaltavano giustamente lo scrittore americano ed evidentemente stimolavano la sua immaginazione), possiamo cercare di produrre narrazioni diverse.
La scienza ai tempi dell’Antropocene
Cosa recuperare della scienza per avvicinarci a un immaginario non-umano? Ci pare chiaro che a navigare il disastro solo con l’immaginazione ci sia il rischio di naufragare se non ci si porta nella propria cassetta degli attrezzi, per esempio, una dose del sano riduzionismo pragmatico tipico del fisico smanettone: se non altro per estirpare la gramigna dell’olismo pasticciato, dell’eclettismo feticistico.
Su questo fronte, uno degli esercizi di immaginazione più gratuiti, radicali e appunto rigorosi degli ultimi tempi è What if? di Randall Munroe. Proviamo: e se l’uomo sparisse improvvisamente dalla Terra, quale sarebbe l’ultima luce artificiale a spegnersi? Ricamandoci sopra: se mai qualche comunità fosse sopravvissuta, come potrebbe utilizzare quell’ultimo barlume per costruire un faro (o una radio, un telegrafo…) e usando il codice Morse ricominciare un principio di comunicazione con altre comunità umane scampate? Esisteva (e probabilmente esiste ancora in qualche aula scolastica, o laboratorio artigiano, o sgabuzzino di ciappinaro) una fisica pratica che faceva toccare quasi con mano le onde elettromagnetiche, la propagazione del calore, la dinamica dei fluidi. Fino a non molti anni fa veniva portata avanti da meccanici e tecnici di ogni tipo, ora espropriati della capacità di mettere mano a motori a benzina, tubi catodici, pietre galeniche e quant’altro dall’avanzamento del digitale e dei relativi strumenti diagnostici. Utilizziamo e siamo utilizzati da una tecnologia che, per quanto affascinante per sofisticatezza, è delicata e liminare. È una tecnologia che non conosciamo ma che ci domina, che ci separa pur dovendo essere teoricamente frutto di una scienza nata per avvicinarsi all’umanità, per “liberare i servi dai padroni” [Brecht, 1963)].
L’ideale di una società scientifica comporta che, per funzionare, tutto il sistema deve reggere, sempre (basti pensare al recente blocco dei treni ad alta velocità dovuto alla manomissione di una singola centralina). Nel disastro – che non è poi così lontano: in questi giorni non è difficile pensarsi senza scampo in un grande incendio perché senza google maps non si ha la possibilità di orientarsi nel “proprio” vicinato – avremo bisogno di tecnologie conviviali, usando una parola cara a Ivan Illich [Illich, 2013]. Strumenti rozzi ma funzionali ad uso pratico di comunità dotate di un sano razionalismo metodologico. E di una biblioteca, dove non potranno mancare delle copie del Low Tech Magazine e di Sustainable energy – without the hot air, del compianto David MacKay.
Tra le varie discipline fisiche da salvare – e per salvarci – c’è anche e soprattutto la termodinamica, a lungo lo zimbello della categoria – nonostante oggi abbia una sua rivincita, a giudicare dalla pervasività della parola “nonequilibrio” (pardon, “nonequilibrium”) nei grant che vengono sottoposti alle autorità che finanziano la ricerca e che, soprattutto, si arrogano (o a cui deleghiamo) di delineare il nostro immaginario scientifico. Ci pare infatti che il “pensare termodinamico” possa e debba essere uno degli strumenti nella cassetta degli attrezzi. Ma che tipo di attrezzo è? Artur, amico e ricercatore tra i più profondi e sensibili che abbiamo incontrato, diceva spesso: “la termodinamica è una specie di contabilità”. Molto poco sexy, ma è tutto lì. La termodinamica intanto è il retropensiero che nulla viene gratis. Che cosa sia quel qualcosa che non è nulla, e quanto costi quel qualcosa che non è gratis, dipende strettamente dal contesto: e qualsiasi altra parola aggiunta al discorso (energia, entropia, entalpia etc.) non fa altro che – se va bene – articolare il pensiero in un altro linguaggio oppure – se va male – spostare il problema un passo più in là. In ogni caso c’è da rimboccarsi le maniche e capire che cosa sono per noi quelle pratiche che migliorano la nostra esistenza, e qual è il prezzo da pagare.
Questa visione da focolare domestico è però ancora troppo limitata. Rinsobrendo dall’ebbrezza della globalizzazione e del suo antagonismo, si torna a casa con una qualche idea che quello che facciamo ha implicazioni sottili con tutto il resto del mondo. “Termodinamica” può allora diventare la predisposizione d’animo di chi, munito dell’armamentario tecnico della fisica, intende intuire, decostruire e ricostruire i flussi materiali e immateriali che sottendono i fenomeni, nella loro interazione e complessità.
Non più tracciare mappe statiche di dove stanno le cose (i famosi potential landscapes), ma un esercizio di pensiero sistematico del movimento. Un treno a idrogeno a Berlino non è “a impatto zero”, perché l’idrogeno sul pianeta Terra è già (quasi) tutto bruciato. Rendere possibile il treno a idrogeno a Berlino implica relazioni di potere che mobilitano energie, informazioni, materia, ma anche microbi, ecosistemi, scarti organici e inorganici, da e per luoghi molto distanti del pianeta. Maria Kaika in City of Flows ha tentato una simile analisi allo studio delle città. David Peat, fisico dilettante e poi etnografo ancora più dilettante, ha comunque colto in Blackfoot Physics che il linguaggio naturale di alcune tribù di nativi americani era tutto incentrato sulle azioni, sui processi, e non sulle cose: non la nube, ma il suo passaggio, il suo piovere, il suo diradarsi. E certo, non è quasi mai vero che esistano precise relazioni causali tra i fatti del mondo. I flussi si diramano dappertutto.
L’animismo è ortogonale al riduzionismo. E dato che sarà difficile scrollarci di dosso la modernità scientista, come possiamo fare della termodinamica il nostro animismo riduzionista, o il nostro riduzionismo animista? Come in Indigo di Clemens Setz, l’indagine razionale in un mondo irrazionale – o viceversa: l’indagine fantastica di un processo meccanico – può non avere mai né inizio né fine, e può portare al puro spaesamento.
Che fare? Uno per tutti…e ognuno per sé?
Far leva sulle narrazioni come strumento di resistenza non significa, però, relativizzare e nemmeno scrivere solo di collasso climatico, ma porsi il problema, ben più complesso, di come si fa mitopoiesi – di più, una cosmopoiesi collettiva in cui immaginare il dopo con l’ambizione e l’umiltà di inserirsi nel flusso naturale di una storia non-solo-umana. Nel 1781, Restif de La Bretonne pubblicava il suo Lettre d’un singe aux êtres de son espèce, in cui una scimmia consola i suoi simili per la barbarie a cui gli esseri umani li hanno costretti e, nel farlo, dimostra come l’uomo sia la prima vittima delle invenzioni e delle tecniche che lo rendono padrone della natura: siamo sempre stati capaci di immaginare le derive e la fine, ma non (più) le possibili soluzioni. Il dominio dell’uomo sulla natura è un paradigma difficile da decostruire: nasce dalle forme di dominio dell’uomo sull’uomo, si è sviluppato contagiando ogni forma dello stare al mondo, tanto da farci credere che davvero fosse il solo modo possibile.
Il filosofo Murray Bookchin, parlando di ecologia sociale, diceva: “se non faremo l’impossibile, ci troveremo di fronte l’impensabile!” [Bookchin, 2016]. La Grande Estinzione propone il percorso inverso: allargare ciò che è pensabile per agire in un modo efficace sul possibile che ci resta, presentandosi come un recupero di attitudini situazioniste, dove però si intende fare un passo ulteriore. Non si tratta solo di un agire che deve prevalere sul sognare, ripescando la critica che i situazionisti hanno avanzato ai contemporanei surrealisti, ovvero il loro rinchiudersi nella meraviglia del sogno, segno di un’incapacità di realizzare nel reale un nuovo modus vivendi. Per Meschiari, realtà e immaginario sono reagenti attivi, al di là dell’assemblaggio: componenti per un unico processo, che non ha un prodotto come risultato se non il divenire stesso in narrazioni capaci di rompere la statica causalità lineare dell’agire e di trasformare la rete attraverso la rete medesima. Ma come si fa davvero rete e come si (ri)diventa comunità? E se ci fossimo abituati a essere liberi di immaginare e credere ognuno per sé, se non fossimo disposti a rinunciarvi, è tanto meglio estinguersi che essere salvi tutti? Inoltre, scienza e tecnologia che ruolo hanno nel concreto? Non è troppo “antropocentrico” dire che l’unica tecnologia dev’essere quella del nostro immaginario? E se invece, come scrive De Landa [De Landa, 1991], lo sviluppo tecnologico avesse un suo proprio momento, visto che tale sviluppo non è sempre guidato da necessità umane, e quindi ormai andasse ricompreso anch’esso in questa visione animistica? Forse sarebbe più facile salvare tutti? Anche i batteri ingegnerizzati sono tecnologie, bio-tecnologie. Nell’immaginario attuale sono le tecnologie che causano l’Antropocene e non l’uomo di per sé. Magari non si tratta tanto di avere una “stele di Rosetta”, la comprensione va molto al di là della traduzione e il termine “collettività” andrebbe meglio definito. I metodi e le pratiche definiscono le collettività, la scienza è una pratica e in quanto condivisa da un insieme di persone aiuta in quel processo di astrazione che serve per immaginare l’invisibile. Si potrà mai ricomprendere in queste pratiche tutti, se tutti sono l’intera popolazione mondiale umana?
Proiettarsi è comunque un esercizio complesso, per cui è necessario porsi in quella che Ghosh chiama l’esistenza “al congiuntivo” [Ghosh, 2017], che la letteratura ha il potere di evocare: se è necessario spostarsi in un altro mondo per non morire al mondo precedente, è fondamentale partire per questo viaggio equipaggiati degli strumenti essenziali del cammino: le mappe e una direzione. Le prime mappe che hanno accompagnato gli esseri umani nella navigazione del mondo sono state le lingue, i miti. Mappe cognitive, mappe simboliche, strumenti materiali di sopravvivenza. Le mappe sono l’unico mezzo per smettere di occupare lo stesso territorio e iniziare a vivere lo stesso mondo. Forse per creare nuove mappe, nuovi paesaggi-linguaggi, la scienza dell’immaginario ha bisogno a sua volta delle scienze naturali per conquistare nuove frontiere. Per quanto riguarda la direzione, una buona proposta è l’utopia, termine coniato da Tommaso Moro per un paese ideale (οὐ τόπος, luogo che non c’è): un’architettura di luoghi possibili quindi, tanto più preziosa nei momenti penultimi. Se riusciremo a farne un viaggio di molte curiosità e di riferimenti condivisi, l’Antropocene sarà l’occasione per accorgerci che viviamo tutti a ridosso della fine e scegliere se esserne spettatori, guardiani o ribelli: nonostante tutti gli immaginari (quello scientifico compreso) le tecnologie – che pure abbiamo creato – continueranno a dire che stiamo estinguendoci, se non facciamo qualcosa – “facciamo politica!”, esorta Agamben in un recente intervento.
“Il destino viene scritto nel momento stesso in cui si compie”
diceva il biologo Jacques Monod per deformazione professionale [Monod, 2001]. Già l’epigenetica ha mostrato che il codice dell’eredità consiste in molto più che una sequenza di lettere, che si può agire a diversi livelli, che questi livelli ricomprendono l’esperienza di quell’organismo nell’ambiente in cui vive. Chissà se l’Antropocene riuscirà a farci fare lo stesso, trovando una nuova quadra: un immaginario che unisca riduzionismo e animismo, scienza e narrazione, azione e linguaggio.
Bibliografia
Albrecht, Glenn. “‘Solastalgia’. A new concept in health and identity.” PAN: Philosophy Activism Nature 3 (2005): 41.
Alinei, Mario and Benozzo, Francesco. DESLI: dizionario etimologico-semantico della lingua italiana. Pendragon, 2015.
Anders, Günther. L’uomo è antiquato. Bollati Boringhieri, 2007.
Brecht, Bertolt. Vita di Galileo. Einaudi, 1963.
Bookchin, Murray. Per una società ecologica. Tesi sul municipalismo libertario e la rivoluzione sociale. Elèuthera, 2016.
Davies, Dame Sally, Jonathan Grant, and Mike Catchpole. The drugs don’t work: a global threat. Penguin UK, 2013.
de Landa, Manuel. War in the age of intelligent machines. Zone Books, 1991.
Safran Foer, Jonathan. Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi. Guanda 2019
Ghosh, Amitav. La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile. Neri Pozza, 2017.
Hossenfelder, Sabine. Lost in Math: how beauty leads physics astray. Brilliance Corporation, 2018.
Illich, Ivan. Convivialità. Red edizioni, 2013.
Kaika, Maria. City of flows: Modernity, nature, and the city. Routledge, 2004.
Kopenawa Davi, and Bruce Albert. The falling sky. Words of a Yanomami Shaman. Belknap Press, 2013.
Khun, Thomas. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Einaudi, 2009.
Monod, Jacques. Il caso e la necessità. Mondadori, 2001.
Peat, David. Blackfoot physics: A new journey into the Native American universe. Newbury Port, MA: Weiser Books (2002).
Restif de la Bretonne. Lettre d’un singe aux êtres de son espèce. 1781
Sandal, Massimo. La malinconia del mammut. Il Saggiatore, 2019.
Setz, Clemens J. Indigo. Suhrkamp Verlag, 2012.
Spadaccini, Giovanni. Giambattista Vico: Immaginazione, Immagine, Immaginario. Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Filosofia, 2010.
Twain, Mark. 3.000 anni fra i microbi. Feltrinelli, 1996.
Woit, Peter. Neanche Sbagliata. Codice, 2007.